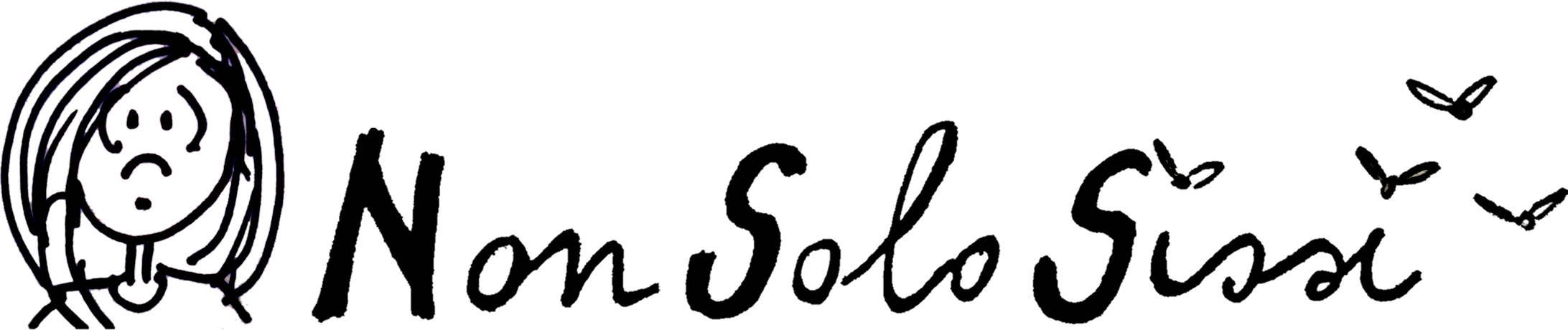Lo shock culturale
Tanti anni fa, in una galassia molto lontana, esistevano ancora i programmi trainee delle grandi aziende. Ogni multinazionale degna di questo nome ne aveva uno. In sostanza le aziende assumevano giovani neolaureati freschi d’università, gli insegnavano qualcosina di utile, poi li sparpagliavano nelle varie sedi in giro per il mondo. A volte per qualche mese, i più fortunati anche un anno. I fortunatissimi facevano persino più giri in Paesi diversi. Alla fine del programma ti offrivano un bel contratto, in genere nel tuo Paese di provenienza.
L’avrete capito, è così che sono finita a Vienna. Non per scelta, ma per caso, mandata qui da – come la chiamavano i ragazzi del mio programma – Mamma-Fiat. Ebbi la fortuna di acchiappare per la coda la moda dei trainee programs, e il mio era persino bello polposo. Un anno e mezzo a botta, tre giri diversi in Paesi in cui esistesse un’azienda del gruppo.
Mamma-Fiat curava questo programma da diversi anni e aveva fatto tesoro dell’esperienza negativa dei primi gruppi: cioè l’altissimo tasso di autolicenziamento per alcune combinazioni di Paese di provenienza/Paese di destinazione. Mi spiego: per qualche misterioso motivo gli Italiani sembravano reggere meglio la Cina dei Francesi, gli Americani davano fuori di testa in Italia, dove invece i Sudamericani si trovavano benissimo.
Le prime settimane di corso si tenevano quindi a Londra, e consistevano in un gigantesco workshop sul tema interazione tra culture diverse e soprattutto shock culturale. L’esperienza più interessante della mia vita, imbattuta fino ad oggi.
Il gruppo di cui facevo parte era, invero, internazionale di brutto. A raccontarlo sembra sempre l’inizio di una pessima barzelletta. Una manciata di Italiani, una di Tedeschi, Francesi, Argentini, alcuni Polacchi, Americani, un Brasiliano, un’Olandese, palma d’oro dell’esoticità ad un ragazzo paraguayano. Per sperimentare lo scontro culturale ci bastava fare due chiacchiere a colazione.
Ricordo ancora con affetto una scenetta capitata durante un pranzo alla mensa aziendale. Intorno al tavolo io, due italiani, un tedesco, un argentino, un brasiliano e Edith, una ragazza olandese alta e sottile, capelli biondissimi e occhioni azzurri, che pareva una fatina delle favole. Si parlava di bidet, questo oggetto misterioso che in molti si erano ritrovati in bagno a tradimento. Edith, una volta capito l‘utilizzo corretto dell’oggetto, lo trovò disgustoso. E mentre masticavamo la cotoletta ci fece un breve discorso sul perché e il percome. Mentre lei blaterava allegramente (non ricordo l’argomentazione esatta, ma un vago “your body juices all mixed up”), solo il Tedesco annuiva serio. I maschi italiani arrossivano visibilmente e sghignazzavano; il ragazzo argentino, imbarazzatissimo, non sapeva più da che parte guardare. Il brasiliano addirittura sputò il boccone nel tovagliolo, si alzò e si allontanò dal tavolo col conato del vomito. Evviva sempre la multiculturalità!
Per un paio di settimane, dunque, ci rinchiusero in un albergo in un sobborgo di Londra insieme ad un professore di Oxford (un genio del quale ho tristemente dimenticato il nome), che ci illuminò sul processo di ambientamento in una cultura a noi aliena.
La teoria prevede quattro fasi, che possono variare in termini di tempo e intensità. (Fonte Wikipedia)
La prima è la luna di miele, che in genere dura da qualche settimana a qualche mese. È la fase in cui si osserva e scopre il Paese ospitante per la prima volta, in cui le differenze paiono intriganti, divertenti, interessanti e persino geniali. I classici occhialoni rosa.
Segue la fase di negoziazione, durante la quale si continuano a notare sempre più differenze, senza però provare più l’emozione della novità. Piuttosto scivolando nell’ansia.
Segue poi la fase più lunga, l’adattamento. Le abitudini locali smettono di sembrare irrazionali o faticose, e sopraggiunge un senso di normalità.
Per finire in bellezza si raggiunge la fase di padronanza, che non vuol dire necessariamente assimilazione, ma il semplice sentirsi a proprio agio nella cultura di accoglienza. Da qui in poi possiamo iniziare a usare tutte quelle belle parole come multiculturale e cosmopolita. Son soddisfazioni.
Questa la teoria. E pare quasi scontata: non è difficile immaginare i problemi cui si va incontro trasferendoci in Cina o India. Le differenze sono talmente gigantesche!
Meno banale è – sorprendentemente – spostarsi di poco. Vi racconto ora quale sia stata la mia esperienza pratica, di Romana a Vienna, tasso di esoticità zero spaccato, distanza fisica tra Patria e Paese ospitante al minimo storico.
Ero partita con la mia bella imbottitura di teoria sullo shock culturale, fermamente convinta che non mi sarebbe servito.
“C’è persino un confine fisico tra Italia e Austria, perbacco, che razza di differenze ti vuoi aspettare? Impara il tedesco e via.”
Questo dicevo ridendo ai compagni di corso con destinazioni più lontane. E mi sbagliavo.
La fase luna di miele è stata lunga e violenta. Sarà anche che venendo su da Roma bastava poco per mandarmi in brodo di giuggiole. Il tram che passa puntuale rispettando l’orario appeso al palo della fermata; l’ufficio per la pratica burocratica aperto tutti i giorni, senza fila, con dentro un impiegato gentile che mi spiegava le cose in inglese. Ieri per caso ho letto questo in rete, le impressioni di un napoletano che ha trascorso un fine settimana a Stoccolma. Ecco, io mi sentivo proprio così, Alice nel Paese delle Meraviglie.
A credere alla teoria, durante questa fase l’espatriato cerca la compagnia dei locali, ma solamente di quelli ben disposti nei confronti degli stranieri, e con cui riescano a comunicare facilmente (in genere in Inglese). Confermo in pieno: sono anche stata un po’ fortunella, ma le prime persone con cui feci amicizia erano due ragazze austriache. Luise, che parla cinque lingue e ha vissuto in tre Paesi diversi, e Alexandra, madre scandinava e Erasmus in Danimarca. Insieme a Roger-L’Olandese-Posato costituirono il nocciolo della mia neonata vita sociale.
La seconda fase, la negoziazione, è stata più sottile, quasi infida. Era la fase che io credevo di saltare a piè pari, e che mi ha invece causato parecchie difficoltà. No, perché la teoria che avevo imparato è pensata piuttosto per Statunitensi scaraventati in Bangladesh. Parla di barriere linguistiche, differenze in termini di igiene pubblica, sicurezza stradale, qualità e disponibilità di cibo. E poi anche di flora intestinale, medici e ospedali, farmaci diversi. Tutti fattori che contribuiscono al senso di isolamento e frustrazione.
Ora, a parte la difficoltà con il tedesco, che non si risolve certo in qualche mese, gli altri fattori mi facevano scompisciare dalle ristate. Igiene pubblica? Mancherà anche il bidet in bagno, ma arrivando da Roma nelle stazioni della metro viennese io avrei leccato il pavimento! Sicurezza stradale? Mi state prendendo in giro? Ho smesso da pochissimo di ringraziare con un cenno del capo gli automobilisti che si fermano per farmi attraversare sulle strisce (cioè tutti)! E sul cibo non fatemi nemmeno cominciare, mancheranno i biscotti del Mulino Bianco, ma al supermercato si trovano l’80% dei prodotti italiani a cui ero abituata. E pure della stessa marca.
Credevo quindi, in piena buona fede, di non avere niente da negoziare. E proprio a causa di questa convinzione ci ho messo parecchio tempo, probabilmente più del necessario, a capire che invece avevo molto da imparare anch’io.
Il primo sospetto mi salì la volta che stavo aspettando Alexandra ad una fermata della metro. Mi chiamò sul cellulare avvertendomi di essere cinque minuti in ritardo. Ci rimasi malissimo. Perché io, da brava Italiana, mai avrei avvertito di un ritardo inferiore al quarto d’ora. Anzi, manco lo avrei considerato ritardo; al massimo tolleranza.
Cominciai quindi a guardarmi intorno con occhi diversi e mi accorsi con orrore di parecchie differenze. A quanto fosse alto il mio volume di voce in confronto ai colleghi raccolti intorno al tavolino della pausa caffè. A come gli amici asburgici invitati per cena suonassero il campanello all’orario stabilito, spaccando il secondo. Alla vecchina che mi diede un’ombrellata sugli stinchi perché avevo accennato ad attraversare la strada sulle strisce col semaforo pedonale rosso.
“Ma non arriva nessuna macchina!” avevo protestato.
“Ci sono bambini che guardano!” mi rispose secca. Sarei volentieri sprofondata nell’asfalto della Mariahilferstrasse.
E ancora, alla volta che in fila al supermercato il tipo dietro di me mi chiese se poteva passare avanti.
“Certo, ma guardi che non sono io la prossima alla cassa”.
Mi ignorò e chiese anche alla signora davanti a me. Che si premurò di spiegarmi
“Bisogna chiedere a tutti, cominciando dalla fine della fila, perché sta passando avanti a tutti, non solo al primo”. Una cosa di una civiltà inaudita, che come prima reazione mi suscitò una risata scomposta. Della quale, immediatamente, mi vergognai.
Avrei molti, moltissimi altri aneddoti da raccontare, il succo è che un pelo di alienazione lo sentono tutti. È un vago fastidio, uno spiacevole senso di frustrazione difficilissimo da identificare. Volendo si potrebbe paragonare – in piccolo – alla sensazione di leggera estraneità che si prova rientrando in casa propria dopo una lunga vacanza. Tutto è al proprio posto, ma la vaga sensazione di distacco rimane; una sorta di minuscolo jet-lag anche senza aver attraversato fusi orari. O svegliarsi la mattina in una camera d’albergo, e per qualche istante sentirsi perso. Con la luce sbagliata, il comodino troppo alto, l’interruttore del bagno che non si riesce a trovare. Ci vuole un pochino di tempo, tutto qui.
Proprio durante questa fase della negoziazione si possono combinare pasticci notevoli. Oltre ovviamente ad offendere di brutto i nativi. Il più classico è stabilire che il Paese ospitante fa schifo. Che la lingua è troppo ostica e non vale la pena impararla. Che usi e costumi sono ridicoli, cafoni, esagerati. Il resto della vita da espatriato sarà poi, fatalmente, un inferno piastrellato di malinconia, tristezza e arrabbiature feroci. Un errore meno grave ma comunque difficile da raddrizzare è quello di cercare di sopperire alla mancanza di appigli certi facendo troppa comunella tra connazionali. Che certo sono un balsamo per le ferite sanguinanti del povero espatriato, ma andrebbero presi a piccole dosi. Curano infatti solo il sintomo, ma non la malattia. E poi uno, dopo anni, si ritrova con la voglia di integrarsi ma ormai la vita sociale è partita decisa su quei binari e cambiare rotta costa il doppio della fatica.
Sono tuttora convinta che sia stato proprio questo a salvare me. Non ho cercato la compagnia di altri Italiani, a parte Enzo che mi era capitato seduto accanto sul classico volo Roma-Vienna della domenica notte, pieno zeppo di espatriati in rientro. Alexandra, Luise, Roger e la loro girandola di amicizie viennesi erano e rimasero il centro della mia vita sociale. Tornavo ancora in Italia con incredibile regolarità, non ero però esclusivamente Italo-dipendente.
Di integrazione ho già blaterato, e pure profusamente, nelle scorse settimane, non c’è quindi bisogno che mi dilunghi sulla fase finale, quella della padronanza. La piacevole e confortevole sensazione che si prova quando si padroneggiano non necessariamente due lingue, ma soprattutto due culture.
Ecco allora, l’espatrio non è pane per tutti i denti, ma spesso e volentieri fallisce, o non soddisfa, perché abbiamo questa scimmia sulla schiena chiamata shock culturale. E manco ce ne siamo accorti.
PS Non pensiate che una volta raggiunta la padronanza della cultura straniera una si possa finalmente rilassare, eh! Informo chiunque abbia gestito con successo lo shock culturale, che esiste anche un rovescio della medaglia: lo shock di rientro. Sono appena tornata da due settimane a Roma e confermo: la prima settimana se ne è andata tutta in arrabbiature e patemi. Solo dopo sono riuscita a calmarmi e a godermi l’Italia.